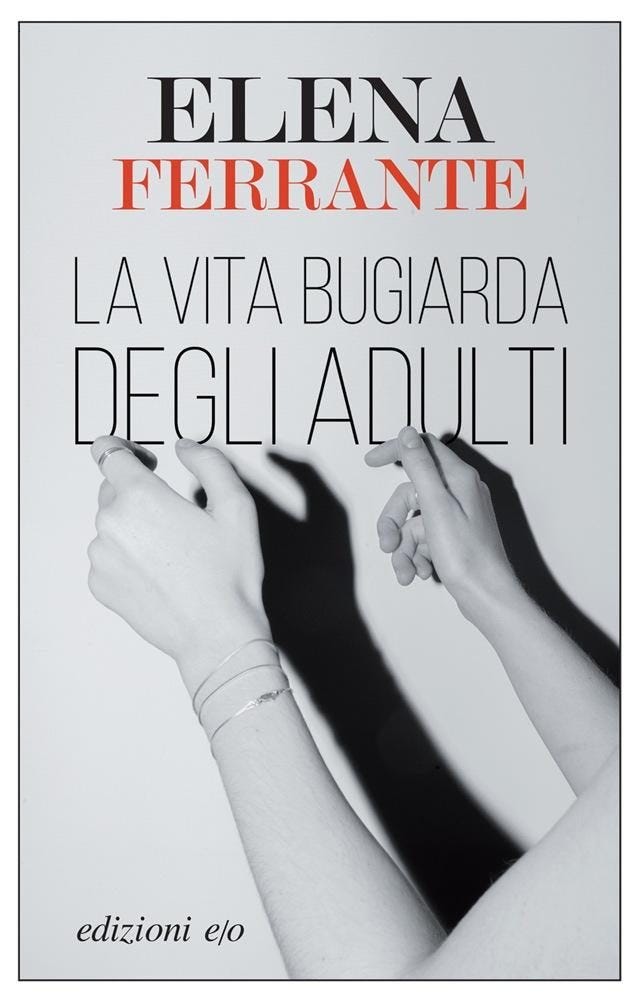Bentornati a Il riepilogo mensile!
In questa newsletter racconto ogni mese i miei consumi mediatici. A volte c’è anche un testo introduttivo che funge da editoriale, ma a questo giro no perché non ho niente di interessante da dire. Passiamo subito ai piatti forti del mese:
📖 Letture: abbandonarsi alla lettura di Elena Ferrante.
🎞️ Visioni: un’emozione che non provavo da tempo: andare al cinema con mia moglie.
🎵 Ascolti: mi sono ricordato dei Belle and Sebastian.
🕹️ Backlog: Inside, breve ma intenso.
🔗 Link: forza Napoli sempre e altre cose belle dell’Internet.
Buona lettura!
📖 Letture
Una rubrica in cui parlo dei libri che ho avuto sul comodino negli ultimi tempi.
Ci sono libri che si leggono per il gusto della trama, per lasciarsi sorprendere dai colpi di scena, per viaggiare in luoghi mai nemmeno immaginati. E poi ci sono libri che si leggono per farsi travolgere da un fiume in piena. Ho sempre visto i romanzi di Elena Ferrante come esponenti di quest’ultima categoria. Finora avevo letto soltanto la quadrilogia de L’amica geniale - una delle migliori letture fatte negli ultimi anni - ma di recente sono andato per la prima volta oltre i confini della storia di Lila e Lenù, affrontando il suo romanzo più recente.
La vita bugiarda degli adulti (2019, Edizioni e/o) mi ha preso sin dall’incipit:
Due anni prima di andarsene di casa, mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto - gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole - è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento.
In questo estratto c’è in nuce tutto ciò che mi è piaciuto del libro (e, per estensione, tutto ciò che mi piace di Elena Ferrante): le frasi a effetto, le invenzioni visive, l’uso consapevole della punteggiatura, i sentimenti estremi, gli scorci di Napoli. Immagino ci sia anche tutto ciò che a molti non piace della Ferrante, che ha uno stile di scrittura che si ama o si odia. Come ho scritto sopra, assume spesso la forma di un fiume in piena: se fai resistenza affoghi, ma se ti ci abbandoni lo ricorderai per sempre.
Non c’è una vera e propria trama in La vita bugiarda degli adulti, ma forse perché la Ferrante racconta personaggi, più che storie. La vicenda è un coming of age ambientato negli anni ‘90, vissuto attraverso la voce narrante di Giovanna, un’adolescente che si scontra con famiglia, amiche, ragazzi, col mondo intero forse, e che finisce col subire il fascino di una zia - Vittoria - di cui i genitori le avevano sempre nascosto l’esistenza. Il tutto è poco più di una scusa per tratteggiare i personaggi, le loro psicologie e le loro relazioni, nel modo impareggiabile che riesce alla Ferrante. Come il tutto si tenga in piedi è uno di quei misteri di cui sono felice di non conoscere la soluzione.
Il romanzo si immerge fino alla vita nel turbamento adolescenziale, esplorato dal punto di vista femminile: il corpo che cambia, la bruttezza che ci si sente addosso, le amicizie che si frantumano, la scoperta della sessualità. C’è una tale consapevolezza nell’attraversare questo universo, e una tale sensibilità nell’affrontare questi temi, che mi risulta difficile anche solo ipotizzare che, alla fine della fiera, la Ferrante possa essere un uomo.
Non riuscivo più a essere innocente, dietro i pensieri c'erano altri pensieri, l'infanzia era finita.
Il braccialetto, da qualsiasi lato lo si esaminasse, in qualsiasi tipo di storia lo si inserisse - una favola, un racconto interessante o banale - metteva in evidenza soltanto che il nostro corpo, agitato dalla vita che gli si torce dentro consumandolo, fa cose stupide che non dovrebbe fare.
E in mezzo a tutto questo ci sono sprazzi di lirismo bellissimi:
[…] finché non arrivò l'autobus. Ci salii come se ogni passo fosse conclusivo e io stessi per dilagare a sorpresa dentro un'altra mia storia e un'altra mia esistenza.
Il tempo della mia adolescenza è lento, fatto di grandi blocchi grigi e improvvise gibbosità di colore verde o rosso o viola. I blocchi non hanno ore, giorni, mesi, anni, e le stagioni sono incerte, fa caldo e freddo, piove e c'è il sole.
I rapporti tra i personaggi sono il cuore pulsante del romanzo, e in essi si concretizzano diverse sotto-tematiche. C’è il contrasto tra i quartieri borghesi e quelli operai, tra chi si esprime in italiano e chi conosce solo il dialetto, tra cultura e religione. C’è Napoli in tutte le sue contraddizioni, tra chi si rifugia nei quartieri bene e chi non riesce a tirarsi fuori dallo squallore della periferia1. C’è la barriera tra la spensieratezza dell’infanzia e - appunto - il mare di menzogne della vita adulta:
"Forse sarebbe tutto meno complicato, se si dicesse la verità"
"La verità è difficile, crescendo lo capirai, è una cosa per cui i romanzi non bastano"
"L'amore è buono, supera anche le lunghe assenze, resiste a tutto"
"Non sai niente, Giannì, parli in italiano ma non sai niente. L'amore è opaco come i vetri delle finestre dei cessi"
La vita bugiarda degli adulti è un libro che ho letto con gran gusto, non tanto per vedere dove mi avrebbe condotto, ma per capire come lo avrebbe fatto. Ho trovato la seconda metà meno riuscita della prima - forse anche perché il personaggio di Vittoria viene ridimensionato e trova meno spazio - ma complessivamente è un romanzo molto bello. Ve lo consiglio? Penso che dobbiate trovare da soli la risposta, perché è pur sempre Elena Ferrante: studi statistici hanno dimostrato che metà di voi lo adorerebbe, l’altra metà lo troverebbe indigesto.
⭐ Voto: 4 / 5
🎞️ Visioni
Una rubrica in cui parlo di film o serie tv che ho visto di recente.
Questo mese sono andato al cinema insieme a mia moglie. Non succedeva dall’estate del 2023 - quasi due anni fa - quando il richiamo di Barbie fu più forte di ogni cosa. La volta precedente era stata nel febbraio 2020, quando vedemmo 1917: era prima della pandemia ma soprattutto prima dei figli, e se da un lato sembra ieri, dall’altro ho l’impressione che sia passata un’intera era geologica.
La genitorialità ci ha dato - e ci continua a dare - tantissimo, ma ha preteso dei tributi in cambio: uno di questi è stato parte del nostro tempo libero congiunto, cioè quello che possiamo permetterci di trascorrere insieme, senza prole al seguito. Prima dei figli andavamo spesso al cinema, a vedere film di ogni tipo: e infatti a volte prendevamo delle cantonate assurde, ma non importava, perché quello che contava di più era vivere l’esperienza della sala.
Uno dei nostri riti preferiti era la combo kebab + cinema (nello specifico il Lux di Roma, che negli ultimi anni era stato il nostro multisala di riferimento). Qualche giorno fa, grazie all’aiuto provvidenziale dei nonni, abbiamo potuto ripetere l’esperienza nella sua interezza. Quel kebab è sempre il più buono di tutti, c’è poco da fare; e la sala ha un suo fascino ancora intatto, nonostante lo streaming ci metta a disposizione tutto e (quasi) subito - o forse proprio per questo.
Ah già, il film. Di fronte a tutta questa emozione, vi dirò che è passato quasi in secondo piano. Comunque, abbiamo visto Paternal Leave di Alissa Jung.
Un classico film drammatico italiano, qui nella variante co-produzione italo-tedesca. La quindicenne tedesca Leona (l’esordiente Juli Grabenhenrich) scopre di avere un padre italiano (Luca Marinelli), che non ha mai conosciuto. Parte così per una piccola località della costa romagnola, dove in tre giorni proverà a costruire un rapporto col genitore.
Era esattamente il film che mi aspettavo di vedere, nel bene e nel male. Funziona la scelta di non doppiare i dialoghi, che sono in inglese, tedesco e italiano, con sottotitoli dove necessario. Funziona l’ambientazione balneare fuori stagione. Funziona il cast ridotto all’osso, in buona parte formato da attori alla prima esperienza. Funziona meno lo sviluppo della storia e gli esiti un po’ fumosi cui conduce. E funziona meno anche la durata, forse appena un po’ troppo lunga.
Sapevo che Paternal Leave non era propriamente un film nelle mie corde, ma chissenefrega: quello che contava, stavolta, era andare al cinema in due.
⭐ Voto: 3 / 5
🎞️ In poche righe
Per un motivo o per un altro, negli ultimi mesi mi sono trovato a colmare diverse lacune tra i cult anni '80. Questo mese è toccato a Ladyhawke di Richard Donner (1985), film che, nonostante all'epoca sia stato un flop commerciale, è poi entrato nell'immaginario collettivo. E forse era meglio se rimaneva solo lì, in effetti: raramente ho visto pellicole invecchiate così male dal punto di vista audiovisivo (le micidiali musiche sintetizzate che accompagnano i combattimenti mi fanno ancora sanguinare le orecchie). Che poi, fosse solo quello: tra buchi di sceneggiatura, duelli coreografati malissimo e pesci lessi che recitano (qualcuno ha detto Matthew Broderick?) non so proprio da dove cominciare. Meno male che in un paio di punti mi sono addormentato. Belle però le location abruzzesi. Si trova nel catalogo Now.
⭐ Voto: 2 / 5🎵 Ascolti
Una rubrica in cui parlo di musica senza avere alcuna competenza.
Da qualche settimana sono iscritto alla newsletter Le canzoni de Il Post, in cui Luca Sofri - ormai ex direttore della testata - parla di una canzone al giorno, dal lunedì al venerdì. Spesso i brani che consiglia non mi interessano e neanche li ascolto, ma mi piace il modo in cui Sofri parla di musica, quindi due minuti al giorno per leggerla li spendo sempre.
In uno dei primi numeri che ho ricevuto (questo, accessibile solo agli abbonati) parlava della sua canzone preferita dei Belle and Sebastian, e io mi sono ricordato di questo gruppo indie scozzese che ho scoperto nei primi anni 2010, e che spesso e volentieri torno ad ascoltare. Conosco solo una minima parte della loro discografia, arrivata ormai a dodici album in studio (il primo è del 1996), e infatti la canzone citata da Sofri non la conoscevo: si tratta di Sleep the Clock Around (dall’album The Boy with the Arab Strap, 1998), e a giudicare dal milione e passa di ascolti su YouTube deve essere piuttosto famosa - per la cronaca, è piaciuta molto anche a me.
Mi sono così chiesto quale sia la mia canzone preferita tra quelle che conosco dei Belle and Sebastian - una domanda piuttosto inutile, forse. Mi piacciono molto Another Sunny Day, Wrapped Up in Books e Get Me Away From Here, I’m Dying, tutti pezzi notissimi; eppure, la prima canzone che mi viene in mente quando penso a questo gruppo è un’altra. Si intitola The Loneliness of a Middle Distance Runner (che gli vuoi dire a un titolo così?), era il b-side di un singolo del 2001, poi incluso nella raccolta Push Barman to Open Old Wounds del 2005. Questo per dire che è forse una delle canzoni meno note dei Belle and Sebastian, ma a me piace troppo il suo andamento, il modo in cui si sentono le corde delle chitarre all’inizio, la parte strumentale a metà e il crescendo finale.
🕹️ Backlog
Una rubrica in cui cerco di conciliare videogiochi e vita adulta.
Quando, lo scorso dicembre, vi avevo parlato di Limbo, avevo chiuso dicendo che non vedevo l’ora di provare il gioco successivo di Playdead, Inside. Tanta era la curiosità di proseguire in questo solco, che ho fatto uno strappo alla regola che mi sono autoimposto, e cioè di non comprare altri titoli finché non ho smaltito il backlog. Promessa da marinaio, lo sapevo già in partenza: e così durante gli ultimi saldi di Steam mi sono portato a casa questa celebratissima chicca.
Inside (2016, Playdead) è un cinematic platform con i comandi ridotti all’osso - destra, sinistra, su, giù, salto, azione - condito da qualche puzzle qua e là: la stessa formula di Limbo, ma elevata all’ennesima potenza. Con Limbo condivide anche un difetto non da poco, e lo voglio dire subito così mi tolgo il pensiero: a livello narrativo costruisce, costruisce e costruisce; ma poi alla fine tutto si sgonfia nel non detto, nell’ambiguità, nel non spiegato. A molti il gioco è piaciuto proprio per questo - e gli ultimi quindici minuti sono potentissimi, lo ammetto - ma più passa il tempo e meno apprezzo la mancanza di chiarezza nelle opere narrative. Un finale così aperto a svariate interpretazioni - in rete se ne trova non meno di una dozzina - finisce con l’essere controproducente, almeno per me, e mi ha lasciato con un po’ di amarezza.
Per quanto importante, si tratta comunque dell’unico difetto di Inside. Che dura poco - l’ho finito in quattro ore - ma è stata un’esperienza di grandissima intensità. Nel gioco impersoniamo un bambino - le similitudini con Limbo non le conto più - che sembra in fuga da qualcuno o qualcosa, e che finisce con l’attraversare diversi scenari (un bosco, una fattoria, una città, un’area industriale) mentre è braccato da uomini misteriosi.
L’intera avventura, dall’inizio alla fine, è caratterizzata da un’atmosfera opprimente. Il bambino si muove in un mondo distopico, in cui le persone non hanno volto (letteralmente), un regime di polizia controlla ogni cosa, gli individui sono ridotti a zombie senza identità. Inside è pieno di dettagli disturbanti (gli animali morti a inizio gioco, i corpi sott’acqua, quella cosa che succede alla fine), per non parlare della tensione che deriva da certe sequenze in cui il giocatore, per scelta di design, si salva all’ultimo secondo (i cani che ti inseguono, le “sirene” che nuotano verso di te, la mimetizzazione in fila dietro gli automi). È un gioco che non sfocia mai nell’orrore, ma che gli danza sempre attorno lasciandoti addosso un gran senso di inquietudine.



Il merito è senza dubbio anche della messa in scena. I sei anni intercorsi dalla pubblicazione di Limbo si vedono tutti: l’evoluzione grafica è impressionante da tutti i punti di vista2. Non c’è più il bianco e nero, ma i colori sono desaturati e su ogni cosa domina il grigio. Ma soprattutto c’è un lavoro sulle luci e sulle ombre eccezionale, degno di una produzione cinematografica: dai fari delle auto nella foresta all’alba dopo la pioggia, passando per le luci e il pulviscolo nelle sequenze subacquee, è incredibile come tutte le sequenze più memorabili di questo titolo siano caratterizzate da scelte di illuminazione che non si dimenticano3.
Non è un caso se Inside è un cinematic platform, genere che affonda le proprie radici nella notte dei tempi4 ma che anche grazie ai titoli di Playdead ha conosciuto una seconda giovinezza. C’è un elemento che avvicina più di ogni altro questo gioco al cinema, ed è il movimento della telecamera. Era uno degli aspetti che più mi avevano colpito in Limbo, ma qui mi ha lasciato davvero a bocca aperta: di fatto Inside è un unico, lunghissimo piano sequenza, con la telecamera che inquadra lateralmente il protagonista e avanza insieme a lui, passando dietro elementi di scena, alzandosi come se fosse un carrello, ruotando per creare angolature a effetto. Considerato che il gameplay è ridotto all’osso, volendo uno potrebbe anche goderselo come un film interattivo (o guardarselo su YouTube: c’è chi lo finisce in meno di due ore).
Al netto della sua ambiguità narrativa - che, chiaramente, è una scelta consapevole degli autori - Inside mi è piaciuto molto. Si tratta anche di un gioco soddisfacente dal punto di vista degli enigmi, che sono piuttosto vari e che ho trovato persino meno sfidanti di Limbo (che già non era un titolo difficile, anzi). A questo punto non vedo l’ora di giocare il prossimo gioco di Playdead, che però è ancora in sviluppo e non si sa quando uscirà. Aspetterò fiducioso.
⭐ Voto: 4 / 5
Inside è disponibile per PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e iOS.
🔗 Link
Una raccolta dei migliori contenuti in cui mi sono imbattuto in giro per il web questo mese.
Non so se avete saputo che il Napoli ha vinto il quarto scudetto della sua storia: è il momento perfetto per perdere qualche abbonato e affermare che si tratta della squadra per cui tifo da sempre. Tutto ciò che ho da dire sull’argomento l’ho messo nero su bianco due anni fa in questo post sul mio vecchio blog, scritto in occasione del terzo scudetto.
Which Year è un sito semplice: ti mostra cinque foto senza alcun contesto, e tu devi indovinare in che anno sono state scattate. Più ti avvicini, più punti ottieni. Può creare dipendenza.
Il giornalista Dario Marchetti - che tra le altre cose cura uno spazio settimanale dedicato ai videogiochi su RaiNews - ha lanciato questo mese Videoludica Obscura. Si tratta di una newsletter settimanale che vuole affrontare i videogiochi in modo diverso dalla stampa di settore, e per questo merita tutta la vostra attenzione.
Grazie per aver letto la newsletter anche questo mese. Ci sentiamo a fine giugno, ciao!
Molti dei luoghi citati nel libro si trovano tra i quartieri Arenella e Vomero, che ho frequentato sin da bambino andando a trovare i miei nonni: via San Giacomo dei Capri, piazza Medaglie d’oro, piazza Vanvitelli, il parco della Floridiana. Mi fa sempre un certo effetto sapermi orientare nella geografia letteraria di un romanzo.
Al momento in cui scrivo (maggio 2025), Inside - pubblicato nel giugno 2016, cioè nove anni fa - è il videogioco più recente cui abbia mai giocato. Decidete voi se questa affermazione fa più ridere o più riflettere.
E anche da un comparto sonoro stellare. I suoni ambientali sono parte integrante dell’esperienza, così come l’ansimare del bambino o i suoi piagnucolii nei momenti di tensione. Ancora una volta, consiglio l’uso delle cuffie per godersi questi dettagli al meglio.
Uno dei primi videogiochi di cui ho memoria - Prince of Persia (1989) - è considerato l’iniziatore dei cinematic platform. In un certo senso, io e questo genere siamo legati a doppio filo da tutta la vita.