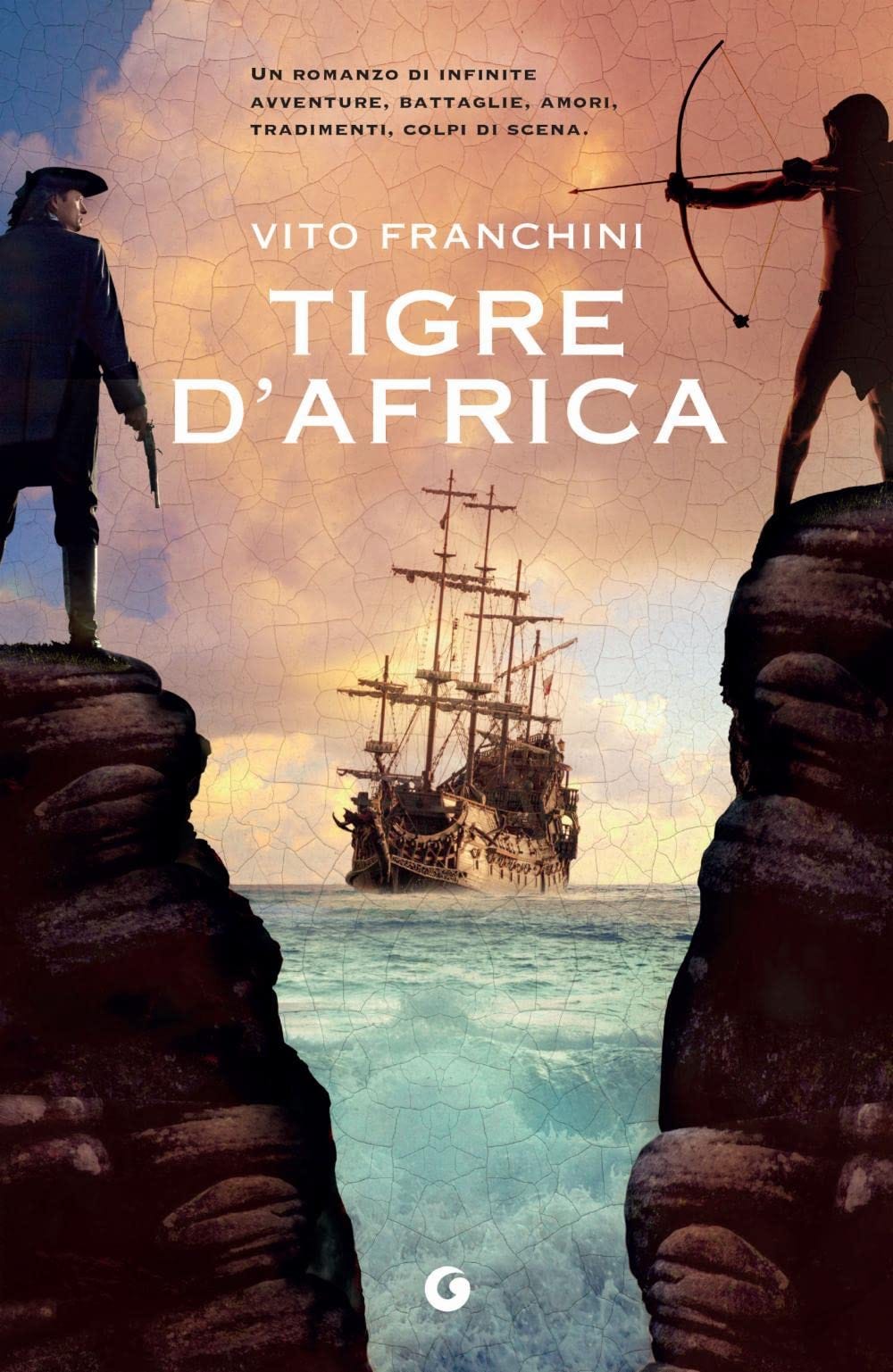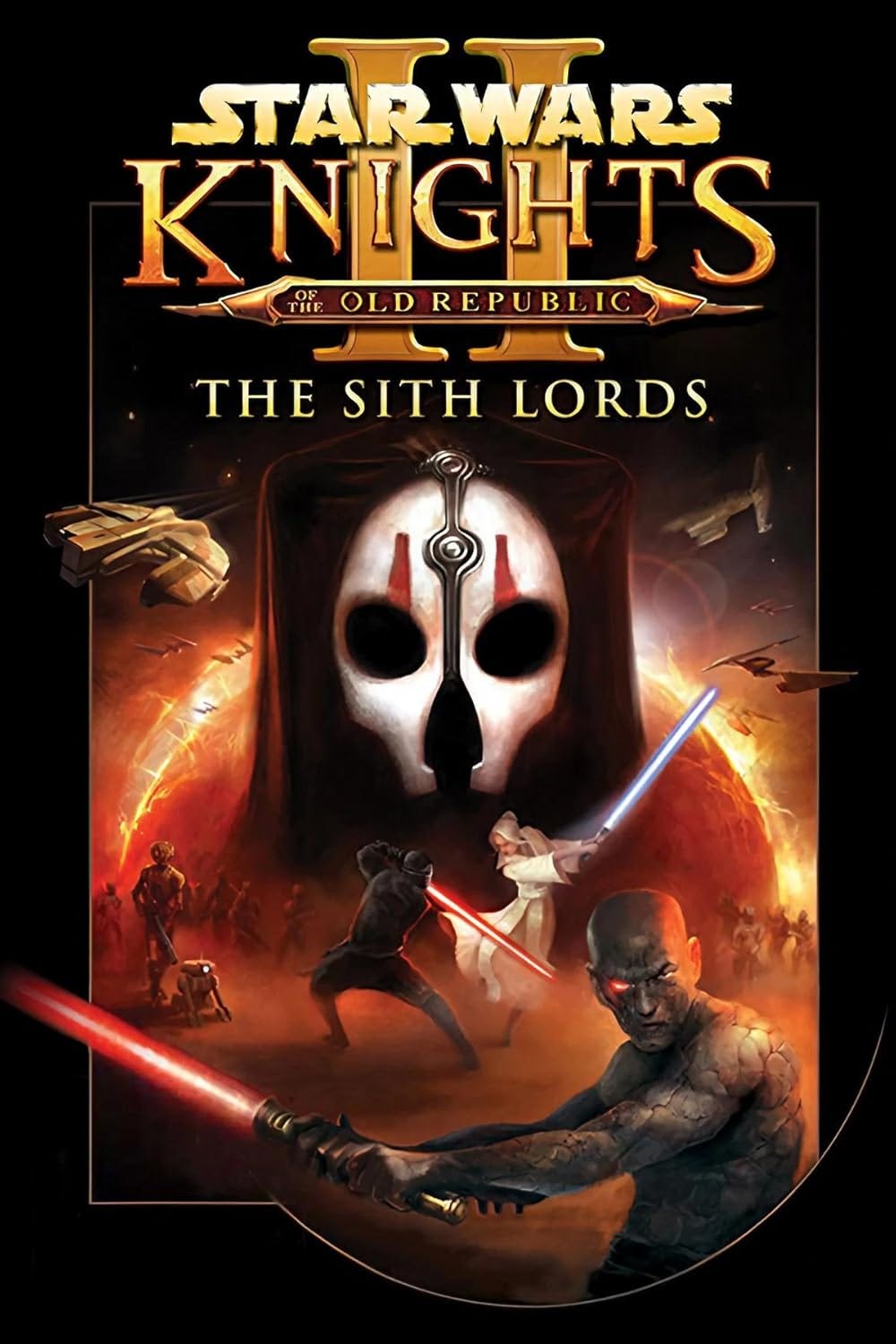Bentornati a Il riepilogo mensile!
E benvenuti a tutti i nuovi lettori! Nelle ultime settimane vi siete iscritti in parecchi, e per una newsletter che arriva una volta al mese è un importante voto di fiducia. Quindi grazie, per prima cosa.
Il riepilogo mensile è il luogo dove parlo dei miei consumi mediatici, con tutte le riflessioni che ne scaturiscono: troverete quindi libri, film, serie tv, canzoni, videogiochi e qualche link interessante pescato nel web; di tanto in tanto, ci sarà spazio anche per aggiornamenti sulla mia attività di scrittore. Qui trovate l’indice in ordine alfabetico di tutto ciò che è già apparso nei numeri precedenti.
Questo mese gli argomenti sono tanti, per cui la faccio breve e passo direttamente alle rubriche tematiche:
📖 Letture: osservatorio romanzo d’avventura: Tigre d’Africa di Vito Franchini.
🎞️ Visioni: recuperando la quinta stagione di The Handmaid’s Tale.
🎵 Ascolti: Canzoni per anni spietati, il ritorno dei Negrita.
🕹️ Backlog: ho giocato al sequel di uno dei miei videogiochi preferiti. Come sarà andata?
🔗 Link: un viaggio in Corea del Nord e cose varie che compiono gli anni.
Buona lettura!
📖 Letture
Una rubrica in cui parlo dei libri che ho avuto sul comodino negli ultimi tempi.
Lo scorso anno avevo dedicato due edizioni di questa rubrica (gennaio e giugno) alla mia personale ricerca del romanzo d’avventura perduto. La mia tesi è che questo genere sia sempre meno presente sugli scaffali delle librerie, finendo spesso con l’essere ibridato con altri filoni di maggior richiamo (il giallo, il thriller, il romanzo storico). Tuttavia, quando nel 2022 ho esordito proprio con un romanzo d’avventura, ho osservato in prima persona la reazione del pubblico, che mi è sembrato affamato di questo genere di libri (o magari erano tutti molto compiacenti, vai a sapere).
Qualche mese fa, scorrendo i suggerimenti di Amazon, mi è balzato agli occhi Tigre d’Africa di Vito Franchini (2023, Giunti), che ha da subito catturato la mia attenzione: perché si presenta come un romanzo d’avventura classico, perché ha un’ambientazione originale, perché è pubblicato da un grosso gruppo editoriale e perché è scritto da un autore italiano. Tutti elementi che me lo hanno fatto leggere con gli occhi dello scrittore intento a svolgere una ricerca di mercato, più che con quelli del lettore.
Inizio XVIII secolo, costa orientale dell’Africa meridionale. Separata dal mondo da alte scogliere e un braccio di mare, Shasmahal è una città utopica: fondata quarant’anni prima dal navigatore inglese Nicholas Suburban, ha accolto un’umanità eterogenea proveniente da luoghi e culture diverse, con l’obiettivo di creare una società autonoma, pacifica e giusta. L’idillio si rompe quando una squadra di mercenari cinge d’assedio la città, rimasta fino ad allora un segreto al resto del mondo. Toccherà a Madhat, nipote del leggendario fondatore, intraprendere un viaggio alla ricerca di un modo per salvare la “città meravigliosa”.
Un romanzo d’avventura, dicevo, e di avventura qui ce n’è senza dubbio parecchia. A una prima parte ambientata a Shasmahal - che serve soprattutto a introdurre la vicenda e i personaggi - ne seguono altre più movimentate: fughe nella savana, guerriglie, assalti a navi, carovane che migrano, vendette incrociate, persino una lunga parentesi in un’arena di gladiatori. Il dinamismo è uno degli aspetti che più mi ha colpito - forse perché mi ero fatto l’idea che la vicenda si sarebbe consumata quasi del tutto all’interno delle mura della città - insieme all’ambientazione. Il concetto alla base di Shasmahal non è nuovo1 ma alcuni dettagli che emergono durante la lettura - come il fatto che i suoi abitanti parlano otto lingue diverse e sono in grado di passare dall’una all’altra nel bel mezzo di una conversazione - li ho trovati intriganti.
Forse l’aspetto che mi è sembrato più riuscito del libro è la sua struttura narrativa. Il romanzo dà e toglie punti di riferimento, con fazioni che si mescolano di pagina in pagina e più antagonisti di quanti si sia portati a pensare all’inizio; Franchini, inoltre, non ha paura di eliminare alcuni dei personaggi principali in modo imprevedibile. Naturalmente, queste scelte hanno un rovescio della medaglia: quando, intorno alla metà del libro, tutto fa credere che gli eventi si stiano avviando allo scontro finale, il lettore capisce subito che le cose non stanno così - altrimenti a cosa servirebbero le successive duecento pagine? Ma in questi casi bisogna stare al gioco.
I punti in cui l’autore inciampa, invece, sono altri. Ho trovato un po’ problematica la gestione dei punti di vista, con il romanzo che alterna in maniera spregiudicata la narrazione dagli occhi di Madhat (protagonista antipatico, ma questo è un parere strettamente personale) a un narratore onnisciente. Qua e là, in maniera estemporanea, vengono introdotti punti di vista aggiuntivi, a volte usati anche solo per un capitolo: mi rendo conto che servono ad arricchire la narrazione, ma mi è sembrata una scelta poco coerente con l’impianto di fondo.
Il difetto peggiore del libro, tuttavia, è a mio parere lo stile. Pur essendo evocativo - il genere e l’ambientazione si prestano - non mi ha saputo conquistare, soprattutto a causa dei numerosissimi infodump che appesantiscono il testo. Non mi riferisco tanto alle spiegazioni necessarie per introdurre il contesto o il passato dei personaggi, quanto ai ripetuti passaggi in cui, nel bel mezzo dell’azione, mi sono trovato a leggere excursus sulla fauna e flora locale, o sulla struttura di una società mercenaria: blocchi inseriti in modo ben poco organico all’interno del testo, che rompono la magia del momento e spezzano la narrazione.
Questi difetti li attribuisco allo statuto particolare del romanzo. Come racconta lo stesso autore, il libro è in realtà un’opera d’esordio che è stata dapprima autopubblicata - col nome di Shasmahal. La città meravigliosa - e solo in un secondo momento è arrivata in libreria per i tipi di Giunti - dopo che Franchini ha pubblicato due thriller con la stessa casa editrice. Mi sono fatto quindi l’idea che il libro risenta un po’ della matrice originaria, per quanto sia stato sicuramente rivisto ed editato in lungo e largo.
Complessivamente, non mi sento di bocciare Tigre d’Africa, che ha diversi spunti interessanti e un’audacia da premiare in alcune scelte narrative. Per quanto sia il primo di un’annunciata trilogia - col secondo capitolo in pubblicazione a maggio - il volume è (abbastanza) autoconclusivo. Non ha placato la mia sete di romanzi d’avventura, ma mi ha confermato che uno spazio per questo genere esiste ancora.
⭐ Voto: 3 / 5
🎞️ Visioni
Una rubrica in cui parlo di film o serie tv che ho visto di recente.
Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, nell’aprile 2017, The Handmaid’s Tale ha fatto il suo debutto in streaming con la prima stagione. Io quel periodo me lo ricordo piuttosto bene, perché ho contribuito - nel mio piccolo - al lancio della serie in Italia2. A quella stagione ne sono seguite altre, e questo mese è arrivata la sesta e ultima, che andrà in onda con un nuovo episodio a settimana fino al 27 maggio. L’occasione è stata utile per me per recuperare la quinta stagione, uscita nel 2022.
Come i lettori abituali di questa newsletter sapranno, io guardo pochissime serie tv. The Handmaid’s Tale è forse la più importante e famosa tra quelle che ho visto negli ultimi anni. Sin dal suo esordio, le tematiche della serie hanno travalicato i confini degli schermi tv, entrando nel dibattito politico, sociale e culturale - soprattutto negli Stati Uniti, dove tre stagioni sono uscite durante il primo mandato Trump. La vicenda, almeno nelle intenzioni iniziali, è distopica; eppure, realtà e finzione si sono piegate fino al punto da essere pericolosamente vicine l’una all’altra. La serie è quindi diventata, a buon ragione, un simbolo di resistenza universale.
Forse è superfluo riassumere la trama di The Handmaid’s Tale, ma lo faccio a beneficio di chi non la conosce. In un prossimo futuro, gli Stati Uniti non esistono più: al loro posto è nata la Repubblica di Gilead, nella realtà dei fatti un regime totalitario e dispotico fondato su una classe dirigente tutta maschile imbevuta di fanatismo religioso (i Comandanti). A Gilead, le donne sono state private di ogni diritto, e vivono in funzione dei diversi ruoli che la società ha loro imposto: le Mogli, unite in matrimonio con i Comandanti, hanno apparentemente uno status sociale più elevato; le Marte servono in casa dei leader, occupandosi delle faccende domestiche; le Ancelle, infine, sono le uniche donne fertili in un mondo in cui il tasso di natalità è crollato, e per questo vengono assegnate ai Comandanti al solo scopo di procreare, nel corso di una cerimonia che è di fatto uno stupro. La serie racconta la storia di June, un’ancella che sceglie di ribellarsi al destino e all’intera società di Gilead.
C’è molto altro rispetto a questo striminzito riassunto che ho fatto in poche righe. Se la prima stagione segue in modo pedissequo la trama del libro omonimo di Margaret Atwood3, quelle successive ampliano progressivamente lo scenario, esplorando la dimensione fantapolitica del racconto e approfondendo diverse tematiche solo accennate - come la discriminazione verso altre minoranze e la resistenza sotterranea che ne consegue. Questa espansione dei confini del mondo è molto evidente nella quinta stagione, che finisce con lo svolgersi in gran parte fuori dai confini di Gilead: un cambio che a mio parere giova alla serie, che altrimenti si sarebbe impantanata in alcune dinamiche ricorrenti.
Questa quinta stagione mi è piaciuta molto. Si ricollega in maniera diretta al finale catartico - e memorabile - della quarta. Il dualismo June / Serena, già emerso in passato, giunge qui alle sue estreme conseguenze. I drammi morali dei protagonisti sono ben sviluppati. Anche i personaggi secondari - tanto quelli storici quanto i nuovi ingressi - sono sfaccettati al punto giusto. Restano poi i tanti momenti intensi: alcuni episodi di The Handmaid’s Tale mi fanno gelare il sangue nelle vene - in senso letterale, è un proprio una sensazione fisica - e questa stagione non fa eccezione.
Mentre vedevo i dieci episodi di questa stagione, mi sono reso conto di aver introiettato a tal punto certi messaggi della serie da averli involontariamente migrati nel romanzo che ho in stesura. È curioso perché non è stato un atto deliberato a tavolino, ma qualcosa che è accaduto e basta: tanto che fino a oggi non me n’ero nemmeno reso conto. Sono le magie del processo creativo, immagino; in ogni caso non mi stupirei se un giorno qualcuno, leggendo certi passaggi del romanzo, vi cogliesse echi di questa serie.
In attesa di vedere la sesta e ultima stagione, non posso che consigliare a tutti The Handmaid’s Tale: che è dura, cruda, a tratti quasi insostenibile, ma racconta un dramma che rischia di non essere più confinato a una distopia narrativa.
⭐ Voto: 4,5 / 5
La sesta e ultima stagione di The Handmaid’s Tale sta andando in onda in esclusiva su TIMVISION. Le stagioni 1-5 sono disponibili sia su TIMVISION che su Prime Video.
🎞️ In poche righe
Christopher Nolan può piacere o meno, ma è innegabile che sia uno dei pochi registi contemporanei capaci di parlare a un pubblico enorme mantenendo una propria identità autoriale. Questo mese ho recuperato il suo film d'esordio, Following (1998): che dura appena 70 minuti - titoli di coda compresi - ed è un compendio del suo modo di fare cinema. Certo, è un'opera prima e si vede, ma il meccanismo narrativo non lineare regge (almeno durante la visione). Al momento è nel catalogo Prime Video.
⭐ Voto: 3,5 / 5
----
Del film più recente di Paolo Sorrentino, Parthenope (2024), si è parlato molto - anche perché è diventato il più grande successo commerciale del regista. È chiaramente una sorrentinata, ma devo dire che è riuscita meglio rispetto ad altre del recente passato: forse avevo aspettative basse, ma il film nel complesso mi è piaciuto e ha alcune belle intuizioni (e altre grottescamente pessime, per carità). Una sorrentinata, appunto, niente di più, niente di meno. Si trova su Netflix.
⭐ Voto: 3,5 / 5🎵 Ascolti
Una rubrica in cui parlo di musica senza avere alcuna competenza.
A fine marzo è uscito il nuovo album dei Negrita, dal programmatico titolo Canzoni per anni spietati.
Il gruppo non pubblicava un album di inediti da sette anni, periodo durante il quale - come hanno raccontato in diverse interviste - hanno subito il contraccolpo della pandemia prima e dell’instabile equilibrio mondiale dopo. Il disco riflette in pieno questo sentimento, declinandolo in un rock arrabbiato e malinconico, politico come è da loro tradizione ma con l’aggiunta del fatalismo di chi ormai si avvicina ai sessant’anni.
Forse le nove canzoni che compongono l’album si assomigliano un po’ troppo, ma comunque i singoli Nel Blu (Lettera ai Padroni della Terra) e Non esistono innocenti amico mio mi sono piaciuti, così come Dov’è che abbiamo sbagliato e Non si può fermare, una disillusa ballata cantata dal chitarrista Drigo.
Inevitabilmente, sono finito a riascoltare sia i pezzi storici degli esordi, sia la loro produzione più recente. Ho cominciato a seguire i Negrita nel momento migliore possibile - tra gli anni del liceo e quelli dell’università - in corrispondenza degli album L’uomo sogna di volare (2005), HELLdorado (2008) e Dannato vivere (2011). In quel periodo li ascoltai anche dal vivo, a Capistrello (L’Aquila): era l’agosto del 2009, pochi mesi prima c’era stato il terremoto, loro vennero e fecero un concerto gratuito di tre ore. Fu molto bello.
Dopo li ho un po’ persi di vista, e gli album successivi sono passati sotto traccia. Con gli ascolti di questo meso ho invece riscoperto pezzi come Un giorno di ordinaria magia (quanto ho ascoltato questa canzone nell’estate del 2012), Il gioco (in cui si sente tantissimo il contributo de Il Cile nei testi), Non torneranno più e soprattutto la stupenda I ragazzi stanno bene, con cui parteciparono al Festival di Sanremo nel 2019. Arrivarono quintultimi.
🕹️ Backlog
Una rubrica in cui cerco di conciliare videogiochi e vita adulta.
I più attenti di voi avranno notato che questa rubrica è saltata il mese scorso4. Il motivo è presto detto: a fine febbraio mi sono imbarcato in un’impresa videoludica che ha richiesto trenta ore per essere portata a termine - il che, tradotto nel tempo della vita adulta, vuol dire un mese e mezzo.
Il videogioco in questione è Star Wars Knights of the Old Republic II - The Sith Lords (2004, Obsidian), che per amor di brevità da qui in poi chiamerò con l’acronimo con cui è universalmente noto: KOTOR II. Ho diverse cose da dire su questo titolo, o per meglio dire sull’esperienza che è stata giocarci: quella che segue quindi non è una vera e propria recensione, quanto una serie di riflessioni.
Una premessa importante, che spiega perché ho deciso di investire tutto questo tempo in un titolo di più di vent’anni fa: il primo KOTOR (2003, BioWare) è uno dei videogiochi più belli cui abbia mai giocato. Lo feci all’epoca della sua uscita, su Xbox, dopo averlo atteso per oltre un anno (le prime immagini le avevo viste su una rivista nel 2002) e dopo aver rischiato di non riuscire a metterci le mani sopra5. Per qualche oscuro motivo, tuttavia, non avevo mai giocato al sequel, uscito poco più di un anno dopo: visto che lo avevo nel backlog di Steam - e considerato che è figlio di cotanto capolavoro - ho deciso di chiudere il cerchio. Non solo: KOTOR II è il titolo di esordio di Obsidian, ancora oggi tra i più importanti sviluppatori di videogiochi di ruolo; mi è sembrata quindi una scelta interessante anche da una prospettiva storica. Infine, KOTOR II all’epoca venne acclamato dalla critica, e tutt’ora è considerato uno dei migliori prodotti ambientati nell’universo di Star Wars, soprattutto per la sua narrazione matura e articolata. Insomma, c’erano tutti gli elementi per stuzzicare il mio interesse.
Molti di voi avranno già capito dove voglio andare a parare con questo lungo preambolo: KOTOR II è stata una grandissima delusione, da molti - se non tutti - i punti di vista. Ho rimuginato molto sul gioco nelle ultime settimane, riflettendoci tra me e me, scambiandomi vocali col mio amico Jacopo (con cui vent’anni fa portai avanti in parallelo il primo KOTOR), leggendo della sua travagliata storia produttiva, e infine scrivendo un post su Reddit che, prevedibilmente, è stato molto commentato (in modo piuttosto civile, va detto6).
Ci sono aspetti strettamente ludici che mi hanno lasciato insoddisfatto - come il combat system e le quest secondarie - ma se volete approfondirli vi rimando al post su Reddit; ci sono poi cose che non ho citato nemmeno lì (come le scelte visive che non mi hanno convinto, o il fatto che giocato sullo schermo della Steam Deck non è il massimo). In questa sede mi concentrerò invece su due aspetti che penso possano interessare un pubblico più ampio.
Il primo è la narrazione, cioè uno dei grandi pregi che la comunità riconosce al titolo. Entrambi i KOTOR sono ambientati 4000 anni prima dei film canonici di Star Wars, ma la storia è più o meno sempre quella: i cavalieri Jedi sono impegnati a difendere la Repubblica contro la minaccia dei Sith e del Lato Oscuro della Forza. Il primo KOTOR aveva un colpo di scena clamoroso, quindi passiamo oltre senza aggiungere altro e arriviamo a KOTOR II, che si svolge 5 anni dopo. La galassia è ancora nel caos per i postumi della guerra civile tra Jedi e Sith, quando una nuova minaccia si profila all’orizzonte (sarà mica l’ennesimo signore oscuro dei Sith?). Il giocatore impersona un Jedi esiliato dal Consiglio per aver seguito il Lato Oscuro e aver provocato una catastrofe: a noi decidere se redimerlo o farlo cadere del tutto.
Ora, KOTOR II è davvero molto legato al predecessore. Ci sono continui rimandi a eventi e personaggi che nella mia memoria sono distanti oltre vent’anni, e nonostante abbia visto un paio di riepiloghi su YouTube, ho fatto fatica a stare dietro al tutto. Non aiuta poi il ritmo dilatato della narrazione: l’incipit è lento e confuso (e ci vogliono quattro ore solo per venire fuori dal prologo), ma poi la storia si prende ancora più tempo per dipanarsi, tanto che gli antagonisti entrano in scena piuttosto tardi nella vicenda. Purtroppo, la confusione aumenta col passare delle ore: alla fine ho dovuto fare ricorso a risorse esterne per capire il senso della trama.
Un discorso a parte va fatto per i personaggi secondari, visto che a spanne il 75% del tempo lo si passa a dialogare con loro. La gestione delle relazioni di amore e odio con i comprimari è forse la parte migliore del gioco. Tuttavia, nel complesso, il cast mi è sembrato meno ispirato rispetto al predecessore, e alla fine il migliore di tutti resta sempre HK-47, un droide dalla personalità assassina che era presente anche nel primo KOTOR. Devo ammettere che alcuni personaggi potenzialmente interessanti non ho avuto modo di approfondirli: nel secondo atto il gioco diventa meno lineare e si può scegliere l’ordine in cui visitare alcuni pianeti, fatto sta che sull’ultimo ho trovato due personaggi che sono risultati sotto-utilizzati, visto che di lì a poco il gioco si incanala verso l’epilogo. Sui nemici, invece, stendo un velo pietoso: a che serve mettere un cattivo con un design pazzesco sulla copertina del gioco, se poi quel personaggio compare in due scene e viene relegato a poco più di una comparsa?
In ogni caso, i tanto decantati temi maturi e adulti sviscerati in ogni dove sul web a me non sono arrivati. C’è una certa cupezza lungo tutto l’arco narrativo, e anche una scala di grigi piuttosto insolita nel delineare la tradizionale dicotomia Jedi / Sith: ma il tutto è presentato in modo frammentario e confuso, e non ha acceso in me la scintilla. Il che mi porta al secondo punto su cui mi voglio soffermare.



“KOTOR2 was the best thing to happen with the Star Wars franchise” ha scritto un utente in risposta al mio post su Reddit, e non metto in dubbio che possa avere ragione. Ma giocare a questo titolo mi ha fatto comprendere che oggi, nel 2025, non ho quasi più interesse verso l’universo di Star Wars; viceversa, quando giocai al primo KOTOR nel 2003, Episodio III era dietro l’angolo e io ero al culmine della mia passione per la saga. Tutti i riferimenti a eventi, pianeti, personaggi solo accennati nei dialoghi di KOTOR II, invece di esaltarmi come avrebbero fatto vent’anni fa, mi hanno infastidito: al punto che sono arrivato a pensare che, se il gioco fosse stato ambientato in un universo narrativo del tutto nuovo, mi avrebbe forse appassionato di più.
Questo per dire che tutta l’enfasi sul fatto che KOTOR II sia un titolo che decostruisce il mito di Star Wars - con i suoi personaggi borderline e il suo angolo tutto particolare sulla Forza - a me è scivolata addosso senza trovare appigli. Probabilmente, se ci avessi giocato all’epoca, avrebbe trovato terreno più fertile su cui attecchire.
Non rimpiango di aver giocato a KOTOR II. Certo, forse trenta ore della mia vita adulta non se le meritava7, ma ho comunque tratto degli spunti di riflessione da questa esperienza. Resta un gioco che poggia sulle fondamenta solide del primo episodio, ma fatica a trovare una propria personalità e fallisce proprio lì dove più lo attendevo, cioè sulla narrazione. Non è un brutto gioco, ma è un sequel molto deludente. Anche se credo che il confronto sia fallato: in fondo, sto confrontando un’esperienza di gioco del 2025 con il ricordo di un’esperienza di gioco del 2003. Forse è tutto qui.
⭐ Voto: 3 / 5
Star Wars Knights of the Old Republic II - The Sith Lords è disponibile per PC, Xbox e Nintendo Switch.
🔗 Link
Una raccolta dei migliori contenuti in cui mi sono imbattuto in giro per il web questo mese.
Il travel influencer Nicolò Balini è stato uno dei primi turisti cui è stato concesso, tra fine febbraio e inizio marzo, di rimettere piede in Corea del Nord dopo cinque anni di totale isolamento (prima che i confini venissero di nuovo chiusi lo scorso 6 marzo). In una serie di cinque video pubblicati sul suo canale YouTube, ha raccontato quello che ha visto - e quello che non gli hanno fatto vedere. Il video da cui partire è questo. Stile molto pop, ma innegabilmente interessante.
In viaggio con Pippo ha compiuto trent’anni. Il Post ne ha approfittato per ricordare questo “feticcio della cultura pop Millennial”, nonché pietra angolare della mia infanzia.
Invece il derby Inter-Milan di Champions League - quello dell’iconica foto di Materazzi e Rui Costa, e di Dida che rotola a terra dopo essere stato colpito da un fumogeno - di anni ne ha compiuti venti. Si tratta di uno dei ricordi sportivi più nitidi della mia adolescenza (e non tifo per nessuna delle due squadre). Marco Gaetani ne ha fatto una retrospettiva su UltimoUomo, con la prospettiva storica che ormai possiamo applicare all’evento.
Direi basta così per questo mese, ci sentiamo tra una trentina di giorni. Ciao!
Io stesso ho utilizzato l’escamotage narrativo della società utopica appartata dal mondo, seppur su scala ridotta, nel mio romanzo Il mondo finisce all’orizzonte. Questo per dire quanto mi affascina il tema.
Ma questa, come si suol dire, è un’altra storia.
In italiano Il racconto dell’ancella, edito da Ponte alle Grazie. Il libro è stato originariamente pubblicato nel 1985. Io l’ho letto nel 2017, dopo aver visto la prima stagione, ed è una lettura che consiglio.
I lettori di Backlog saranno anche in minoranza, ma sono piuttosto accaniti: alcuni hanno protestato a gran voce per l’assenza. Posso rassicurarli dicendo che ho già materiale per coprire i prossimi due mesi.
Storia che non interesserà a nessuno, per cui la relego alle note. All’epoca non c’era la distribuzione digitale, ma la faccenda era soprattutto logistica (CD/DVD, scatole, libretti di istruzioni, ecc). I titoli della LucasArts erano distribuiti in Italia da un’azienda storica del settore, la CTO. Fondata negli anni ‘80 e affermatasi negli anni ‘90, al cambio di millennio aveva perso il suo principale cliente (Electronic Arts, che aveva cominciato a curare la distribuzione in proprio), andando incontro a una crisi che culminò nel 2004 con il fallimento. KOTOR fu uno degli ultimi titoli distribuiti da CTO, per cui arrivò nei negozi poco e male. Dalle mie parti risultò introvabile, ma mia nonna, dietro mio mandato, riuscì a prenderne una copia in una grande catena di Napoli. Solo che non riusciva a leggermi bene il titolo in inglese al telefono, per cui io mi convinsi che aveva comprato un altro gioco di Star Wars. Quando me lo portò e riconobbi la copertina, quasi mi commossi. (Le grandi emozioni dei miei quattordici anni).
Come è noto, Reddit contiene il meglio e il peggio di Internet. Il subreddit dove ho scritto - r/patientgamers - è l’unico che seguo attivamente: un’isola abbastanza felice in cui si parla di videogiochi usciti da più di dodici mesi, e in cui il tono delle conversazioni è in genere pacato, ragionato, e aperto a punti di vista altri.
Se penso che il primo KOTOR l’ho finito due volte - una col finale del Lato Chiaro e una con quello del Lato Oscuro - capisco veramente come il tempo sia un concetto relativo, e che nella mia adolescenza tendeva più o meno all’infinito.