Agosto 2024
Lamenti di fine estate, un libro per sentirsi al fresco, la nuova canzone dei The Killers, e alcuni link interessanti da leggere.
Bentornati a Il riepilogo mensile!
Più passano gli anni, e più mi identifico in questo pensiero del protagonista di Nuovo Cinema Paradiso a proposito dell’estate. Io e l’estate non siamo mai andati d’accordo, nemmeno quando ero bambino: ricordo che l’euforia per le vacanze durava qualche settimana, sostituita ben presto dall’attesa per il ritorno alla vita di tutti i giorni. In fin dei conti, l’estate per me è sempre stata soltanto una parentesi.
Come anticipato il mese scorso, vi confermo che l’estate è in realtà l’inverno dei miei consumi mediatici. Avrei voluto vedere qualche film, e invece l’ultimo risale ad aprile (imbarazzante, lo so). Avrei voluto portare avanti Baldur’s Gate II, e invece non ho mai acceso il pc, nemmeno una volta. Più di ogni altra cosa, avrei voluto scrivere: davvero, venivo da una fruttuosa primavera passata a revisionare il romanzo, ed ero partito con le migliori intenzioni. Non è stato così: troppa stanchezza a fine giornata, troppi malanni (in piena estate!), troppo difficile trovare la condizione d’animo o anche solo il posto giusto. Troppo caldo, soprattutto. Forse è queso ciò che mi rimarrà addosso di questa estate: la consapevolezza che dobbiamo prepararci a estati sempre più roventi, e che, visto che la buona volontà dei singoli non arresterà il cambiamento climatico, dovremo trovare un modo per sopravvivere.
Questa introduzione ha preso una brutta piega, quindi voglio concluderla con una nota positiva. C’è una cosa che effettivamente ho fatto questa estate: ho letto un sacco (per i miei standard, almeno). Si tratta dell’unica attività culturale che non mi ha mai abbandonato da che ho memoria. Per questo cominciamo subito con il resoconto di due letture. Buona lettura!
📖 Letture
Una rubrica in cui parlo dei libri che ho avuto sul comodino negli ultimi tempi.
Approfittando di qualche giorno di ferie, questo mese ho finito di leggere due libri molto corposi. Che vi devo dire, i libri voluminosi mi sono sempre piaciuti, ma ho notato che ormai leggo quasi solo libri dalle 500 pagine in su.
Proprio la mole ha trattenuto per un anno e mezzo sullo scaffale dei libri da leggere The Terror di Dan Simmons: ogni volta che consideravo l’idea di affrontarlo, le sue 789 pagine mi scoraggiavano. L’estate mi è sembrato, alla fine, il momento migliore per leggerlo: e così, mentre fuori la temperatura si avvicinava ai 40°, io mi sono immerso nelle vicende di un gruppo di uomini che rimangono tre anni bloccati a 50° sotto zero. (No, non ha funzionato: non è servito a sentire meno caldo).
The Terror (pubblicato originariamente in Italia come La scomparsa dell’Erebus – e tra i due titoli non saprei dirvi quale è il meno a fuoco) è un romanzo del 2007 che ha avuto una seconda giovinezza nel 2018, quando è uscita con un buon successo la serie tv omonima (in Italia distribuita su Prime Video). Il libro si muove con disinvoltura tra i generi: a prima vista si presenta come un romanzo storico – e c’è un rigore di fondo testimoniato dalla notevole bibliografia presente alla fine del volume – ma ben presto si affaccia sui territori del fantastico e dell’horror.
La vicenda di partenza è quella della spedizione perduta di Franklin, composta da due navi – la Erebus e la Terror – che nel 1845 salparono dall’Inghilterra alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest, un (allora) ipotetico collegamento via mare tra Atlantico e Pacifico a nord del Canada. Quello che sappiamo dalle fonti storiche è che le due navi rimasero bloccate nei ghiacci, e nel volgere di circa tre anni tutti i membri dell’equipaggio morirono per il freddo, le malattie o la malnutrizione.
Ma è in quello che non sappiamo, invece, che Simmons ha ricamato l’intreccio di questo romanzo. L’autore immagina che gli uomini della spedizione abbiano dovuto fronteggiare anche un’altra minaccia, ben più oscura e temibile: un essere soprannaturale venuto fuori dai ghiacci, enorme e assetato di sangue, che un po’ alla volta comincia a fare a pezzi cose e persone.
Narrato da almeno una decina di punti di vista diversi – anche se il capitano della Terror Francis Crozier ha un ruolo preminente – The Terror scorre via una pagina dopo l’altra e, da un certo punto in avanti, per me è stato davvero difficile metterlo giù. Simmons sa come tenere i lettori incollati alla pagina, questo è certo. Lo conoscevo già per la sua produzione fantascientifica: è autore di uno dei miei romanzi di fantascienza preferiti (Hyperion), ma anche di una cocente delusione (il seguito La caduta di Hyperion, che proprio non mi è andato giù), quindi non sapevo cosa aspettarmi da questa sua incursione in un genere differente. Simmons è riuscito a coniugare l’anima storica del romanzo – con lunghe descrizioni della vita di bordo, delle tecniche di sopravvivenza e degli spostamenti sul ghiaccio – a sequenze di tensione e azione orchestrate alla perfezione – cito quella a mio parere più memorabile: la grottesca festa di Capodanno che si risolve in tragedia. Il tutto con un cast corale di personaggi piuttosto ampio (forse anche troppo: un elenco in apertura del volume avrebbe aiutato).
L’edizione italiana riporta in copertina una citazione del New York Times che paragona il libro (anzi, la serie) al film Alien. Il paragone è calzante, soprattutto perché per buona parte del romanzo il mostro non compare sulla scena – o almeno mai interamente – mentre gli esiti delle sue incursioni vengono descritti nei minimi dettagli. E se da un lato la creatura è parte integrante del meccanismo narrativo del libro, dall’altro rappresenta anche il cuore stesso del suo messaggio di fondo. Che emerge in tutta la sua chiarezza soltanto dopo centinaia di pagine e altrettante efferatezze, in un punto ben preciso, quando il lettore viene a conoscenza della sorte del tenente Irving (uno dei pochi personaggi positivi del romanzo): il vero male non è quello che alberga nei mostri, ma quello che risiede negli esseri umani.
The Terror mi è piaciuto, pur con le sue imperfezioni (soprattutto lungaggini: qualche sforbiciata in più gliel’avrei data), ma non lo consiglio a scatola chiusa a tutti: è un romanzo estremo, molto crudo, che non fa sconti al lettore, e ha pure un finale mistico che potrebbe non piacere (secondo me ci sta). Ma se deciderete di imbarcarvi sulla Terror (o meglio, su ciò che ne rimane), state pur certi che la scrittura di Simmons vi catturerà fino alla fine.
⭐ Voto: 4 / 5
La seconda lettura di questo mese è stata La sirena di Posillipo di Paolo Jorio (con la collaborazione di Claudia Carrescia). Ho ricevuto una copia omaggio da parte di una persona che ha collaborato alla realizzazione del libro, e che ringrazio nuovamente. Si tratta di un romanzo che a pelle non avrei scelto in libreria; e avrei fatto male, perché è stata l’occasione per scoprire una storia interessante che non conoscevo.
Il libro si svolge a cavallo del 1600, in gran parte a Napoli, ed è incentrato sulla figura di Adriana Basile, sorella del Giambattista Basile passato alla storia come autore de Lo cunto de li cunti. Anche Adriana ha un talento: quello del canto, che la porta ben presto a frequentare dapprima le famiglie più importanti di Napoli, e poi quelle del resto d’Italia. Ma lo stesso talento dà vita a una faida con un’altra canterina, Angela, orfana di umili origini animata da un odio viscerale verso la Basile; è proprio questo scontro – in gran parte a distanza – a costituire il motore della narrazione. La vicenda copre un arco di oltre cinquant’anni, dalla nascita di Adriana alla sua morte, ed è raccontata attraverso gli occhi di un ampio e variegato cast di personaggi.
Alla fine del volume, una nota degli autori svela quanto c’è di vero – supportato da fonti storiche – e quanto c’è di inventato – non poco, compresi alcuni dei personaggi principali. Per una curiosa coincidenza, ho quindi letto due libri consecutivi che si divertono a mescolare verità e finzione. Come sempre, guardo a questi aspetti soprattutto dalla prospettiva dello scrittore, cercando di capire come si incastrino personaggi storici e fittizi. In questo caso il risultato finale è buono, e non si ha mai l’impressione di assistere a forzature.
La lettura scorre via veloce tra sete di potere, intrighi di palazzo e relazioni più o meno lecite. La sirena di Posillipo è soprattutto un romanzo di donne: fredde, calcolatrici, animate da una fame di rivalsa sociale, non esitano a usare il proprio corpo per raggiungere gli scopi che si sono prefissate. Devo ammettere che ho faticato a entrare in sintonia con le due protagoniste – che a tratti mi sono risultate proprio irritanti – però la rivalità funziona come escamotage per tenere insieme una trama che si dipana su un periodo così lungo. Anche qui qualche taglio in più avrebbe giovato: nonostante il lavoro di semplificazione svolto dagli autori, i personaggi che si alternano sono davvero tanti e talvolta si perde il filo.
Sullo sfondo c’è la Napoli del XVII secolo, che rappresenta qualcosa di più di una semplice ambientazione: viva, caotica, densa di vita e morte, prende vita davanti agli occhi del lettore con descrizioni evocative, e diventa a pieno titolo una co-protagonista del romanzo. A mio parere, la parte più riuscita del libro.
⭐ Voto: 3 / 5
🎵 Ascolti
Una rubrica in cui parlo di musica senza avere alcuna competenza.
A metà mese i The Killers hanno pubblicato un nuovo singolo, Bright Lights, e io non ho potuto fare altro che ascoltarlo a manetta per un paio di settimane. La canzone non fa parte di un nuovo album, ma è stata pubblicata in occasione di una serie di concerti che la band terrà in questi giorni a Las Vegas – città di cui sono originari – per celebrare il ventesimo anniversario del loro album d’esordio (io mi ero portato avanti e ne avevo parlato a maggio).
Questo pezzo ha tutto quello che serve per esplodermi nella testa: le schitarrate, gli arpeggi ripetuti, il crescendo finale e il coro di voci femminili. Una canzone epica che mi ricorda una volta di più che, anche con le barbe ormai ingrigite (o forse proprio per questo), i The Killers rimangono uno dei miei gruppi preferiti.
Ma in questi caldi giorni d’agosto, seguendo percorsi logici misteriosi, sono finito anche a riascoltare I Ratti della Sabina. Wikipedia li etichetta come esponenti del combat folk, un sottogenere musicale dal nome bellissimo; si tratta di un gruppo originario della provincia di Rieti, attivo tra gli anni ’90 e gli anni 2000, che io scoprii col passaparola ai tempi dell’università (poco prima che si sciogliessero, ma ho avuto comunque la fortuna di ascoltarli dal vivo nella loro incarnazione successiva, denominata Area 765). Mi sono sempre stupito di come siano riusciti a valicare i confini del Lazio, eppure hanno fatto centinaia di concerti in giro per tutta l’Italia, e sono contentissimo che abbiano avuto la loro stagione di gloria.
I Ratti della Sabina per me sono comfort food musicale: melodie e testi che mi fanno sentire a casa e mi riconciliano con il mondo. Mi piacciono sia nella declinazione più folk degli esordi, sia in quella più pop/rock degli ultimi anni. Era troppo tempo che non li ascoltavo, nonostante abbiano prodotto alcune delle mie canzoni preferite (tipo Accorda e canta, per dirne una). La cosa bella è che ogni volta incappo in nuovi pezzi che mi piacciono: a questo giro è stato il turno de Il giocoliere, canzone tratta dal loro album Cantiecontrocantiincantina del 2001, in cui omaggiano Gianni Rodari:
Anch’io quando c’avevo gli anni ad una cifra sola
Un giorno l’ho incontrato tra i banchi della scuola
Mi disse: Il tempo ha sempre fretta, porta via le ore
Tu crescerai, ma non scordare quel che oggi hai dentro al cuore
Perché ogni ragazzino ha un mondo fatto di sogni e fantasia
Che poi quando diventa grande troppo spesso per paura butta via
🔗 Link
Una raccolta dei migliori articoli in cui mi sono imbattuto in giro per il web questo mese.
Nella mia bolla social legata a editoria e scrittura è rimbalzato parecchio questo articolo del Post a firma di Niccolò Gangi De Thierry, con un titolo che dice già tutto: “Perché molti scrivono se nessuno li legge?”. Oltre a raccontare la storia di Evandro Straccini – che a me ha fatto più che altro tenerezza – l’autore dell’articolo si interroga sulla necessità che molte persone avvertono di scrivere, o produrre arte in genere. Una riflessione molto interessante, che però a mio parere tralascia un’altra domanda fondamentale: se da un lato è sacrosanto che ognuno abbia il diritto di produrre arte, è altrettanto giusto che tutto ciò che si scrive debba essere pubblicato?
Sempre in zona editoria e dintorni: sul suo canale YouTube, lo scrittore Andrea Viscusi ha fatto una riflessione molto onesta e trasparente sulla sua prima esperienza con una grande casa editrice. Da vedere se volete avere un’idea di come funziona l’editoria in Italia, e quali sono i numeri che ci sono dietro.
Durante le Olimpiadi di Parigi, L’Ultimo Uomo ha pubblicato come di consueto una serie di pezzi lucidissimi sulle storie incredibili che un evento del genere si tira dietro. Eppure, questo mese, porto alla vostra attenzione un altro articolo a sfondo sportivo: questo reportage di Tommaso Rodano sul ping-pong come strumento di redenzione all’interno del carcere di Rebibbia.
Uno degli youtuber che ho scoperto di recente è Diario di un videogiocatore, che produce contenuti videoludici per millennials nostalgici come me. E infatti questo video su come ci si approcciava un tempo ai videogiochi (prima ancora di cominciare l’esperienza di gioco vera e propria) è oro puro – e non ho potuto fare a meno di lasciare un commento.
Dai che l’estate è finita. Ci sentiamo tra una trentina di giorni!





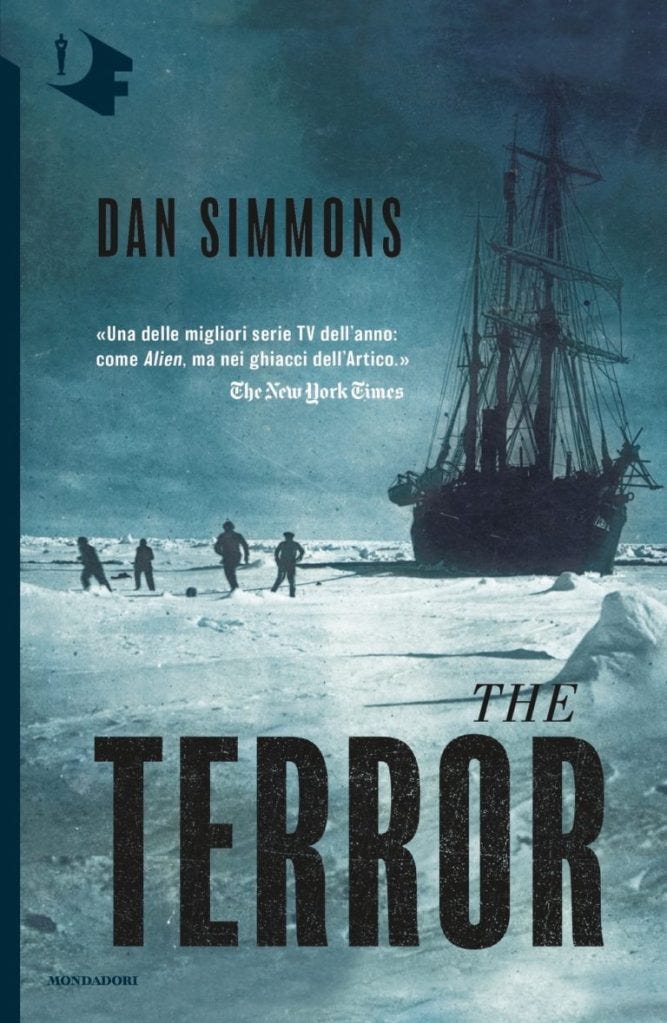
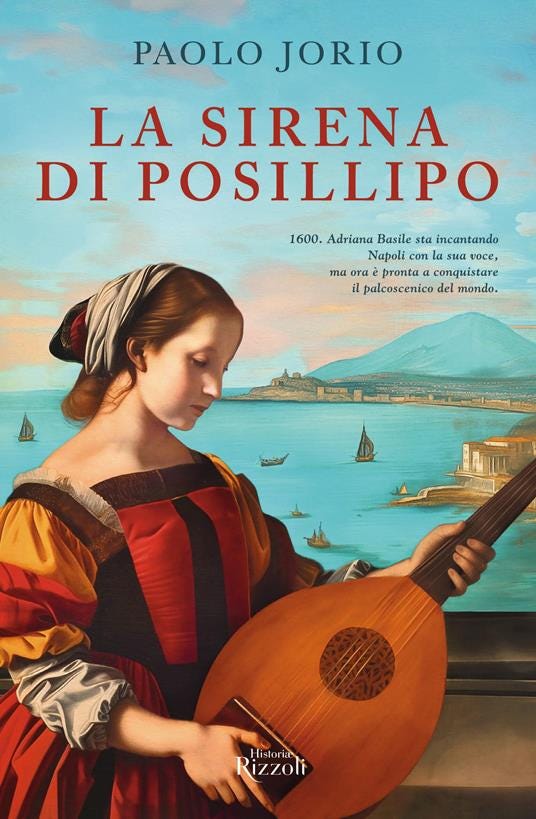
I Ratti della Sabina erano finiti in un angolo dimenticato del mio cervello, grazie!